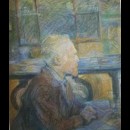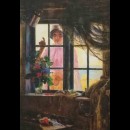| [16,1] Sed ut ad id, de quo agitur, revertar: venti quattuor sunt, in ortum, occasum, meridiem septemtrionemque divisi; ceteri, quos variis nominibus appellamus, his applicantur "Eurus ad Auroram Nabataeaque regna recessit Persidaque et radiis iuga subdita matutinis Vesper et occiduo quae litora sole tepescunt proxima sunt zephyris Scythiam septemque triones horrifer invasit boreas: contraria tellus nubibus assiduis pluvioque madescit ab austro [16,2] Vel, si brevius illos complecti mavis, in unam tempestatem, quod fieri nullo modo potest, congregentur: "una Eurusque Notusque ruunt creberque procellis Africus" et, qui locum in illa rixa non habuit, Aquilo [16,3] Quidam illos duodecim faciunt: quattuor enim caeli partes in ternas dividunt et singulis ventis binos subpraefectos dant |
[16,1] Ma per tornare allargomento in esame: i venti sono quattro, divisi in levante, ponente, meridionale, settentrionale; gli altri, a cui diamo nomi diversi, si possono ricondurre a questi Euro si ritirò verso lAurora e i regni Nabatei e la Perside e le catene montuose esposte ai raggi del mattino Loccidente e le rive che diventano tiepide al tramonto del sole sono molto vicini agli zefiri Il gelido Borea si è impadronito della Scozia e del settentrione: la parte opposta della terra è bagnata dalle nuvole perenni portate dal piovoso austro [16,2] Oppure, se preferisci riunirli in una frase più breve, si riuniscano in una sola tempesta, cosa che non può accadere in nessun modo: Euro e Noto si lanciano insieme e Africo sempre in burrasca e Aquilone che non ha trovato posto nella rissa [16,3] Alcuni contano dodici venti: infatti dividono in tre ognuna delle quattro parti del cielo e danno a ogni vento due venti secondari |
| Hac arte Varro, vir diligens, illos ordinat, nec sine causa Non enim eodem semper loco sol oritur aut occidit, sed alius est ortus occasusque aequinoctialis (bis autem aequinoctium est), alius solstitialis, alius hibernus [16,4] Qui surgit ab oriente aequinoctiali, subsolanus apud nos dicitur, Graeci illum G-aphelioten vocant Ab oriente hiberno eurus exit, quem nostri vocavere vulturnum et Liuius hoc illum nomine appellat in illa pugna Romanis parum prospera, in qua Hannibal et contra solem orientera exercitum nostrum,et contra ventum constitutum venti adiutorio ac fulgoris praestringentis oculos hostium vicit; Varro quoque hoc nomen usurpat, sed et eurus iam civitate donatus est et nostro sermoni non tamquam alienus intervenit Ab oriente solstitiali excitatum G-kaikian Graeci appellant, apud nos sine nomine est |
Varrone, studioso diligente, li classifica così e non senza ragione Infatti, il sole non sorge e tramonta sempre nello stesso luogo, il suo sorgere e il suo tramontare sono diversi a seconda che il sole si trovi allequinozio( e lequinozio si ha due volte lanno), al solstizio destate, o a quello dinverno [16,4] Il vento che spira dalloriente equinoziale noi lo chiamiamo subsolanus, i Greci lo chiamano G-aphelioten Dalloriente invernale proviene leuro, che i nostri hanno denominato volturno, e Livio gli dà questo nome a proposito della battaglia poco favorevole ai romani, in cui Annibale grazie al vento e alla luce che accecava gli occhi dei nemici, sconfisse il nostro esercito schierato contro al sole che stava sorgendo e contro al vento; anche Marrone usa questo nome, ma euro ha già ricevuto diritto di cittadinanza nella nostra lingua, di cui ormai fa parte non più come uno straniero Il vento che nasce dalloriente solstiziale, i Greci lo appellano G-kaikian, da noi è senza nome |
| [16,5] Aequinoctialis occidens favonium mittit, quem zephyrum esse dicent tibi etiam qui Graece nesciunt loqui A solstitiali occidente corus venit, qui apud quosdam argestes dicitur: mihi non videtur, quia cori violenta vis est et in unam partem rapax, argestes fere mollis est et tam euntibus communis quam redeuntibus Ab occidente hiberno africus furibundus et ruens, apud Graecos G-lips dicitur [16,6] A septemtrionali latere summus est aquilo, medius septemtrio, imus G-thrascias: huic deest apud nos vocabulum A meridiano axe G-euronotos est; deinde G-notos, Latine auster; deinde G-leukonotos, qui apud nos sine nomine est [17,1] Placet autem duodecim ventos esse, non quia ubique tot sunt (quosdam enim inclinatio terrarum excludit), sed quia plures nusquam sunt |
[16,5] Loccidente equinoziale invia il favonio, che anche quelli che non sanno il greco faranno corrispondere allo zefiro Dalloccidente solstiziale proviene il cauro, definito argeste da qualcuno: non mi sembra che sia lo stesso vento, perché la forza del cauro è violenta e porta via, mentre largeste di solito è debole e favorevole sia a chi va sia a chi viene Dalloccidente invernale proviene lafrico furibondo e irruente, che i Greci chiamano G-lips [16,6] Da nord-est proviene laquilone, dal nord il vento di settentrione, da nord-ovest il G-thrascias: per questo noi non abbiamo un nome Da sud giunge G-euronotos, poi il G-notos, in latino austro, quindi il G-leukonotos, che da noi non ha nome [17,1] Si ammette poi che i venti siano dodici, non perché ovunque ce ne siano dodici ( alcuni infatti non fanno parte dellorientazione del luogo), ma perché in alcun luogo ne esistono di più |
Maybe you might be interested
Seneca, Naturales Quaestiones: Libro 07; 06-10
Latino: dall'autore Seneca, opera Naturales Quaestiones parte Libro 07; 06-10
| Sic casus sex dicimus, non quia omne nomen men sex recipit, sed quia nullum plures quam sex [17,2] Qui duodecim ventos esse dixerunt, hoc secuti sunt, totidem ventorum esse quot caeli discrimina Caelum autem dividitur in circulos quinque, qui per mundi cardines eunt: est septemtrionalis, est solstitialis, est aequinoctialis, est brumalis, est contrarius septemtrionali His sextus accedit, qui superiorem partem mundi ab inferiore secernit (ut scis enim, dimidia pars mundi semper supra, dimidia infra est) [17,3] Hanc lineam, quae inter aperta et occulta est, id est hunc circulum Graeci G-horizonta vocant, nostri finitorem esse dixerunt, alii finientem Adiciendus est adhuc meridianus circulus, qui horizonta rectis angulis secat |
Così parliamo di sei casi, non perché ogni sostantivo ne possieda sei, ma perché nessuno ne possiede più di sei [17,2] Quelli che hanno sostenuto lesistenza di dodici venti hanno seguito lidea che esistano tanti venti quante sono le costellazioni celesti Ora, il cielo è diviso in cinque cerchi che corrono attorno ai cardini del mondo: il cerchio nord, quello del solstizio destate, quello degli equinozi, quello del solstizio dinverno, quello meridionale, opposto al settentrionale A questi se ne aggiunge un sesto, che divide la parte superiore del mondo da quella inferiore ( infatti, come sai, una metà del mondo è sempre collocata sopra di noi, laltra metà al di sotto) [17,3] Questa linea, che corre fra le regioni visibili e quelle invisibili, cioè questo cerchio, i Greci lo chiamano G-horizonta, i nostri invece lhanno definito alcuni finitor, altri finiens Si deve inoltre aggiungere il cerchio meridiano che taglia lorizzonte ad angoli retti |
| Ex his quidam circuli in transversa currunt et alios interventu suo scindunt; necesse est autem tot aeris discrimina esse quot partes [17,4] Ergo G-horizon, sive finiens circulus, quinque illos orbes quos modo dixi finiens, efficit decem partes, quinque ab ortu, quinque ab occasu; meridianus circulus, qui in horizonta incurrit, regiones duas adicit: sic duodecim aer discrimina accipit et totidem facit ventos [17,5] Quidam sunt quorundam locorum proprii, qui non transmittunt sed in proximum ferunt; non est illis a latere universi mundi impetus: atabulus Apuliam infestat, Calabriam iapyx, Athenas sciron, Pamphyliam crageus, Galliam circius (cui aedificia quassanti tamen incolae gratias agunt, tamquam salubritatem caeli sui debeant ei: divus certe Augustus templum illi, cum in Gallia moraretur, et vovit et fecit) |
Partendo da questi corrono in modo trasversale certi cerchi che intersecano gli altri e li tagliano; ma esistono necessariamente tante suddivisioni dellatmosfera quante sono le regioni del cielo [17,4] Quindi, lorizzonte o cerchio delimitante, delimitando quei cinque cerchi che ho appena nominato, dà origine a dieci parti, cinque a oriente, altrettante a occidente; il cerchio meridiano che incontra lorizzonte, aggiunge due regioni: così latmosfera ha dodici suddivisioni e fa nascere altrettanti venti [17,5] Alcuni appartengono a determinati luoghi, e non li oltrepassano, ma soffiano nelle immediate vicinanze; essi non prendono la loro forza dai lati estremi del mondo: latabulo infesta lApulia, lo iapige la Calabria, lo scirone Atene, il Crageo la Panfilia, il circio la Gallia (e, anche se esso rompe gli edifici, tuttavia gli abitanti lo ringraziano in quanto credono che a esso debbano la salubrità del clima: in ogni caso il divino Augusto durante il suo soggiorno in Gallia, gli consacrò un tempio e glielo costruì) |
Maybe you might be interested
Seneca, Naturales Quaestiones: Libro 01; 08-14
Latino: dall'autore Seneca, opera Naturales Quaestiones parte Libro 01; 08-14
| Infinitum est, si singulos velim persequi; nulla enim propemodum regio est quae non habeat aliquem flatum ex se nascentem et circa se cadentem [18,1] Inter cetera itaque providentiae opera hoc quoque aliquis ut dignum admiratione suspexerit: non enim ex una causa ventos aut invenit aut per diversa disposuit, sed primum ut aera non sinerent pigrescere sed assidua vexatione utilem redderent vitalemque tracturis [18,2] Deinde ut imbres terris subministrarent idemque nimios compescerent Nam modo adducunt nubes, modo deducunt, ut per totum orbem pluviae dividi possint: in Italiam auster impellit, aquilo in Africam reicit, etesiae non patiuntur apud nos nubes consistere; idem totam Indiam et Aethiopiam continuis per id tempus aquis irrigant |
Non terminerei mai, se volessi trattare di tutti in modo singolare: infatti, non esiste quasi regione che non possieda qualche soffio che nasca in essa e che venga meno nei suoi dintorni [18,1] E così, fra le altre opere della provvidenza si potrebbe stimare anche questa come degna di ammirazione: essa, infatti, ha creato i venti e li ha distribuiti nelle varie regioni non soltanto per un motivo, ma innanzitutto perché non permettessero allaria di stagnare, ma con un movimento continuo la rendessero utile e vivificante per coloro che lavrebbero respirata [18,2] E poi affinché i venti procurassero le piogge alla terra e le frenassero, se fossero troppo abbondanti Infatti, ora portano le nuvole, ora le mandano via, in modo tale che le piogge si possano distribuirsi in tutto il globo: laustro spinge le nuvole in Italia, laquilone le rimanda in Africa, i venti etesii non permettono alle nuvole di fermarsi dalle nostre parti e sommergono tutta lIndia e lEtiopia con piogge senza fine in quel periodo |
| [18,3] Quid, quod fruges percoqui non possent, nisi flatu supervacua inmixta servandis ventilarentur, nisi esset quod segetem excitaret et latentem frugem ruptis velamentis suis (folliculos agricolae vocant) adaperiret [18,4] Quid, quod omnibus inter se populis commercium dedit et gentes dissipatas locis miscuit Ingens naturae beneficium, si illud in iniuriam suam non vertat hominum furor Nunc quod de C Mario vulgo dictatum est et a Tito Liuio positum, in incerto esse utrum illum magis nasci an non nasci reipublicae profuerit, dici etiam de ventis potest; adeo quicquid ex illis utile et necessarium est non potest his repensari quae in perniciem suam generis humani dementia excogitat |
[18,3] E che dire del fatto che non si potrebbero avere raccolti, se le parti inutili e unite a quelle da conservare non fossero disperse dal vento, se non esistesse nulla che stimolasse il raccolto e, spaccatone linvolucro (gli agricoltori li chiamano follicoli), ne scoprisse il frutto [18,4]E che dire del fatto che ha dato la possibilità a tutti i popoli di stare in contatto e ha mescolato popolazioni sparse qua e là Straordinario beneficio della natura, se la folli degli uomini non lo rivolgesse a proprio danno Ora, quello che è stato spesso affermato di Giulio Cesare e che Tito Livio ha scritto, cioè che non si sa se avrebbe giovato maggiormente allo Stato nascendo o non nascendo, si può anche dire dei venti; a questo punto ciò che di utile e necessario proviene da essi non può bilanciare queste cose che la follia del genere umano escogita a proprio danno |
Maybe you might be interested
Seneca, Naturales Quaestiones: Libro 04; 02,06- 02,10
Latino: dall'autore Seneca, opera Naturales Quaestiones parte Libro 04; 02,06- 02,10
| [18,5] Sed non ideo non sunt ista natura bona, si vitio male utentium nocent: non in hoc providentia ac dispositor ille mundi deus aera ventis exercendum dedit et illos ab omni parte, ne quid esset situ squalidum, effudit, ut nos classes partem freti occupaturas compleremus milite armato et hostem in mari aut post mare quaereremus [18,6] Quae nos dementia exagitat et in mutuum componit exitium Vela ventis damus bellum petituri et periclitamur periculi causa, incertam fortunam experimur, vim tempestatum nulla ope humana superabilem et mortem sine spe sepulturae |
[18,5] Ma se anche diventano dannosi per colpa di chi li usa in malo modo, non per questo non sono per natura beni: la provvidenza e lordinatore del mondo che è Dio hanno affidato ai venti il compito di far muovere laria e li hanno diffusi da ogni parte, affinché nulla marcisse nellinoperosità, e non perché noi riempissimo con soldati armati le flotte destinate ad occupare una parte del mare e andassimo a cercare dei nemici in mare o al di là del mare [18,6] Quale follia ci sconvolge e ci pone gli uni contro gli altri per sterminarci vicendevolmente Spieghiamo le vele ai venti per andare a cercare la guerra e corriamo dei pericoli per correre altri pericoli, tentiamo la sorte con le sue incognite, la violenza delle tempeste che nessuna forza umana può sovrastare e una morte priva di speranza di sepoltura |
| [18,7] Non erat tanti, si ad pacem per ista veheremur: nunc cum evaserimus tot scopulos latentes et insidias vadosi maris, cum effugerimus procellosos desuper montes, per quos praeceps in navigantes ventus impingitur, cum involutos nubilo dies et nimbis ac tonitribus horridas noctes, cum turbinibus divulsa navigia, quis erit huius laboris ac metus fructus, quis nos fessos tot malis portus excipiet Bellum scilicet et obvius in litore hostis et trucidandae gentes tracturaeque magna ex parte victorem et antiquarum urbium flamma [18,8] Quid in arma cogimus populos Quid exercitus scribimus directuros aciem in mediis fluctibus Quid maria inquietamus Parum videlicet ad mortes nostras terra late patet |
[18,7] Non ne varrebbe la pena neanche se attraverso questi pericoli fossimo condotti alla pace: ora, invece, dopo essere scampati a tanti scogli nascosti e ai pericoli del mare pieno di bassifondi, dopo essere sfuggiti alle montagne che ammassano le tempeste sulle loro vette e lanciano sui naviganti un vento impetuoso, ai giorni avvolti da un cielo coperto e alle notti spaventose per i temporali e i tuoni e ai rottami delle navi naufragate a causa delle bufere, quale sarà la ricompensa di tali fatiche e di tali paure, quale porto ci accoglierà stanchi da tante sventure Sarà la guerra e il nemico che ci verrà incontro sulla spiaggia e genti da sterminare, che trascineremo con loro gran parte dei vincitori, e lincendio di città antiche [18,8] Perché costringiamo i popoli a prendere le armi Perché arruoliamo eserciti che si dovranno schierare per la battaglia tra i flutti Perché turbiamo i mari Evidentemente, la terra non dà spazi abbastanza estesi per morire |
Maybe you might be interested
Seneca, Naturales Quaestiones: Libro 02; 01-05
Latino: dall'autore Seneca, opera Naturales Quaestiones parte Libro 02; 01-05
| Nimis delicate fortuna nos tractat, nimis dura dedit nobis corpora, felicem valetudinem; non depopulatur nos casus incurrens, emetiri cuique annos suos ex commodo licet et ad senectutem decurrere: itaque eamus in pelagus et vocemus in nos fata cessantia [18,9] Miseri, quid quaeritis Mortem, quae ubique superest Petet illa vos et ex lectulo, sed innocentes petat; occupabit vos in vestra domo, sed occupet nullum molientes malum Hoc vero quid aliud quis dixerit quam insaniam, circumferre pericula et ruere in ignotos, iratum sine iniuria occurrentia devastantem ac ferarum more occidere quem non oderis |
Il destino ci tratta in modo troppo delicato, ci ha fornito di corpi troppo resistenti, una salute robusta, gli incidenti non ci accadono per distruggerci, ognuno può trascorrere tranquillamente i suoi anni e arrivare alla vecchia: e così andiamo per mare e invochiamo contro di noi un destino che tarda [18,9] Sventurati, che cosa cercate La morte che si trova in abbondanza Essa vi verrà a prendere anche nel vostro letto, ma che vi colga da innocenti, vi coglierà in casa vostra, ma che non vi colga intenti a tramare qualcosa di male In verità, come è definibile, se non follia, il comportamento di chi diffonde intorno a sé i pericoli e si getta contro degli sconosciuti, devastando in preda allira ciò che gli si fa incontro senza offenderlo, e uccidendo chi non odia, come fanno le bestie feroci |