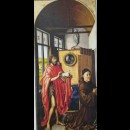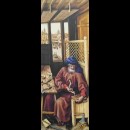Quando abbiamo studiato Tasso, ci siamo soffermati su un episodio in particolare, il duello fra Tancredi e Clorinda. Questo duello è costruito con un certo virtuosismo, con dei riguardi di significato. Tali virtuosismi sono il preludio all'estetica barocca.
Il significato del Barocco è già deducibile dalla sua definizione. Deriva o dal francese bareaux (barò) o dallo spagnolo bergueda. Si insiste sull'immagine di qualcosa che non è regolare, di qualcosa di sregolato, non comune, che dà proprio l'idea del Barocco. Un'altra etimologia è la parola latina "baroco", che fa pensare ad un artificio, cioè un qualcosa che non è nella norma e che non essendo nella norma, è stata costruita in maniera particolare.
La finalità del Barocco è quella di meravigliare e di stupire. Il barocco ha una sua storicità in Italia, ma si sviluppa anche in Francia, Inghilterra e Francia. Di questo periodo ricordiamo proprio William Shakespeare.
Ma come si sviluppa il 600 in Italia? Attraverso quali manifestazioni? Ogni corrente artistica risponde ad una nuova visione della realtà. Nel Barocco, rispetto al 500, è avvenuta la conferma da parte di Galileo Galilei, delle tesi di Keplero riguardanti la considerazione della teoria che la terra non sia al centro dell'Universo, ma giri intorno al sole. Si afferma quindi la teoria eliocentrica, insieme alla nuova scienza galileiana. Attraverso la scoperta del cannocchiale, Galileo rende visibile la superficie della luna. Prima si riteneva che la luna fosse perfettamente liscia, non presentasse alcuna asperità; ma, attraverso la sua invenzione delt elescopio, Galileo mostra il contrario. Queste nuove scoperte mettono in crisi un mondo: fino a quel momento si era sempre ritenuto, che il cielo fosse l'immagine della perfezione, riferimento che si ha anche nel proemio della Gerusalemme liberata, in cui il cielo viene definito "la perfezione". Queste nuove conoscenze creano uno sconcerto nella percezione della realtà: l'uomo si sente infinitamente piccolo rispetto ad un universo infinitamente grande. Si ha quindi da un lato uno sgomento da parte dell'uomo, dall'altra parte il senso del mistero, il mistero che proviamo quando ci troviamo di fronte a qualcosa che non conosciamo.
L'uomo del 600 prova due sentimenti contrastanti: da un lato la paura, lo smarrimento, lo sgomento dell'uomo che si sente solo nella vastità dell'universo; dall'altro lato la curiosità dell'uomo del Barocco, la voglia di voler catturare questo enorme universo. Proprio questo stupore dell'uomo genera la sfarzosità del barocco, che cerca di riempire l'horror vacui (l'orrore del vuoto) con delle rappresentazioni, con delle decorazioni. Tipica del Barocco è, per esempio, l'immagine del teschio, che riguarda il senso del tempo. La percezione del tempo e dello spazio cambiano, poiché la conoscenza si sgancia dalla religione: quando la scienza si sgancia dalla religione, le verità della scienza diventano soggette a cambiamenti, sono cioè vere finchè qualcun altro non prova il contrario. Diventa relativa anche la verità scientifica, che per essere tale non può essere accolta per fede, ma attraverso la pratica della sperimentazione. E' proprio il metodo sperimentale che nasce con Galileo Galilei. Le opere di Galileo Galilei furono soggette al tribunale dell'inquisizione.
Maybe you might be interested
Il 600 e il Barocco: riassunto
E’ il secolo di epidemie e crisi, dove la tensione e la paura vanno a creare un vuoto morale ed etico nei cuori della gente
In base al sistema aristotelico-tolemaico, su cui è anche basata la Divina Commedia, la terra era considerata al centro dell'universo. Galileo Galilei prova il contrario, dimostra che è il sole al centro dell'universo e la terra a girargli intorno. Queste scoperte di Galileo vengono divulgate dapprima in latino, poi in volgare. Questo significa che Galileo voleva diffondere queste sue conoscenze, per far capire a tutti che le cose non stavano esattamente ocme si diceva. Galileo non è un ateo, non è un eretico, ma è un cattolico; asserisce queste cose non per il gusto di andare contro la Chiesa, ma perché ritiene che la Bibbia sia stata scritta in un'epoca in cui si faceva riferimento ad un linguaggio figurato, primitivo, adatto solo ad essere recepito dall'umanità del tempo, e non da quella moderna. Galileo Galilei fu alla fine costretto all'abiura, cioè a ricusare tutto quello che aveva affermato.