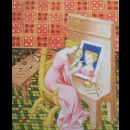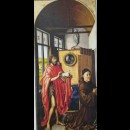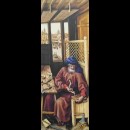Si tratta di un censimento generale del guardaroba di tutte le donne appartenenti alle classi agiate (nobili, patrizi, popolo grasso), effettuato dai notai per poter applicare le recenti leggi suntuarie e tassare tutto ciò che andava tassato.
Le autorità volevano infatti contenere le spese per i beni di lusso, considerati investimenti improduttivi, contrastare le nuove mode ritenute eccentriche e indecenti (abiti aderenti, scollati, variopinti) e mantenere intatte le barriere tra le classi sociali: ciascuno doveva vestirsi in base al proprio status, al proprio rango, alla propria ricchezza, al proprio nome alla propria reputazione. Le leggi suntuarie medievali hanno sempre un carattere moralista, reazionario, classista e misogeno.
Le informazioni furono trascritte in vari quaderni redatti in una calligrafia poco curata, ricchi di abbreviazione di difficile lettura. In tutto abbiamo 3.257 schede che censiscono 6.874 abiti e soprabiti, 276 ornamenti per il capo e un gran numero di accessori di ogni tipo, appartenenti a un totale di 2.420 donne, alcune delle quali figurano più volte. Tale raccolta rappresenta un documento davvero eccezionale, non solo per la storia dell'abbigliamento e della società, ma anche per quella della descrizione e del lessico dei colori
Una giovane donna alla moda, in questo lussuoso manoscritto decorato intorno al 1410-1411 per Luigi di Valois, figlio del re di Francia Carlo VI e appassionato bibliofilo, il rosa è molto presente, sia sugli indumenti sia negli elementi architettonici. La moda del rosa era nata decenni prima nella miniatura e nella pittura italiane; intorno al 1400, nell'Europa occidentale, raggiunge l'apice nelle miniatura, nelle arti preziose e nelle corti.
Studiando questo documento dal valore inestimabile possiamo farci un'idea precisa dei colori in voga nella Firenze dell'epoca. Benché le tonalità siano varie, c'è una netta predominanza dei rossi, soli o associati in motivi dicromatici (scacchi, righe, bipartiti) al giallo o al verde, qualche volta al bianco, più di rado al blu o al nero. La grande moda del nero, che nasceva proprio in quegli anni a Milano, raggiungerà la Toscana solo nel finire del secolo. I notai servendosi di un lessico eterogeneo in cui si mescolano termini latini e volgari, dialettali e tecnici, formule artificiose e veri e propri neologismi, si sforzano di dare un nome preciso a tutte queste sfumature di rosso.
Ne risulta una tavolozza immensa, composta da rossi chiari e scuri, spenti e accesi, uniformi e mescolati, aranciati, violacei e soprattutto tendenti al rosa. Sembra che i tintori Fiorentini fossero diventati dei veri esperti nella gamma dei rossi chiarissimi, poco apprezzati nei secoli precedenti, ed erano in grado di proporre alla loro clientela un ampio catalogo di rosa. Di qui a pensare che l'offerta andasse incontro alla domanda il passo è breve: sembra insomma che prima della peste nera le belle signore fiorentine amassaro vestirsi di rosa.